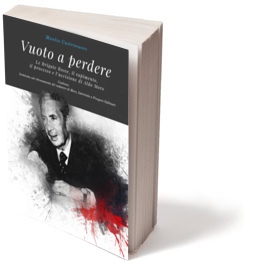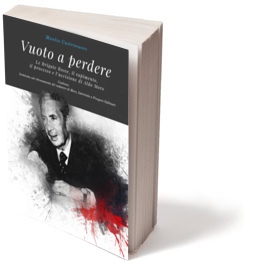|
Moro fu un personaggio politico, e la sua vicenda fu considerata con riferimento unicamente al suo ruolo sociale, come se “il politico” dovesse esaurire la sua intera personalità. La conseguenza fu che ogni comportamento non rientrante all’interno di una logica politica fu rinnegato, sconfessato, condannato. Mai dai politici Moro fu considerato nella sua dimensione di “essere umano”, evidenziando qualità e aspetti che, da un lato, lo avrebbero reso una persona, dall’altro, avrebbero agevolato un’identificazione con lui. Il ruolo ha così soppiantato e oscurato l’individuo, e ancora oggi si parla del politico e non dell’uomo, privandolo dei suoi sentimenti, cioè della sua parte più vera. Ora, è precisamente di questa parte che ho voluto interessarmi, e le domande che mi sono posto sono diventate altre:
«Quali furono le strategie adottate da Moro in una situazione di assoluta emergenza?», «I suoi comportamenti tradirono segni di un disturbo post-traumatico da stress?»,
«Con quali risorse seppe fronteggiare l’angoscia e non cedere a un crollo psicotico?».
Le risposte sono tutte contenute nelle lettere: Moro ha dimostrato di possedere una personalità ben integrata, e ciò gli consentì di conservare fino alla fine un controllo sulla realtà e sui suoi eventi. Moro non ha mai manifestato, attraverso le sue lettere, indizi di una qualche forma di squilibrio, com’è stato talora sbrigativamente suggerito; comunicare questa “verità” mi è sembrato doveroso nei confronti di un uomo che ha saputo, in una situazione d’inaudita violenza, rivelarsi sul piano emotivo e affettivo di una straordinaria maturità.
Cosa si aspettava all’inizio del suo lavoro? E quali bilanci si sente di fare ora che l’ha ultimato?
Ho scritto il libro – come ho accennato - perché impressionato dall’equilibrio psichico manifestato da Moro, dalla sua lucida razionalità nell’esaminare le opportunità di una liberazione, dal suo dominio emotivo nell’affrontare situazioni d’insopportabile angoscia, dall’atteggiamento né sprezzante né remissivo, né intimorito né compiacente sia verso i “vecchi amici” sia verso i “giovani nemici”. Tutto sembrava fosse stato detto della vicenda Moro, eppure di Moro nulla era stato riferito. Questa fu l’anomalia che suggerì la mia curiosità. Non avevo un’ipotesi di lavoro, né una tesi da dimostrare, e l’idea del libro cominciò a prendere corpo soltanto quando iniziai a rendermi conto che il Moro che gli ex amici dichiaravano di non conoscere era in realtà il Moro autentico. Scoprii così un Moro che progressivamente mi convinse come psicologo e mi coinvolse come uomo. Mi sorpresero in lui sensibilità e intelligenza: era dotato di una personalità di notevolissimo spessore, e di una coscienza fuori dell’ordinario. La mia intenzione fu di ripresentare l’uomo che gli amici non riconobbero, invitandoli – a distanza di anni – a guardare e a osservare meglio “se questo è un uomo”.
Mi aspettavo una maggiore disponibilità nell’accoglienza di un Moro ritratto da un diverso punto di vista; mi sbagliavo. Devo riconoscere che Moro, a più di trent’anni dalla sua morte, non è ancora un argomento di cui si parla volentieri. Alcuni “amici”, tra quelli politicamente impegnati, mi hanno scritto, riproponendo puntualmente le ragioni adottate a suo tempo nei confronti di Moro, senza peraltro comprendere neppure un solo intento del mio libro; altri mi hanno comunicato, in vari modi, il loro completo disinteresse per tutta “l’incresciosa” vicenda. La presentazione del libro non ebbe luogo, poiché il relatore si è disimpegnato. Un solo quotidiano accolse di pubblicizzare il volume, ma senza produrre commenti propri. Il disinteresse per Moro è così grande che il mio libro non è stato esposto in nessuna libreria della mia città. Moro non è ancora morto, poiché si continua a ucciderlo.
Si era interessato già da prima del caso Moro o è una vicenda che l’ha interessata solo limitatamente alle sue analisi?
Avevo di Aldo Moro una conoscenza approssimativa e vaga. Attraverso i giornali dell’epoca, avevo seguito gli eventi che si riferivano al suo sequestro e alla sua morte, ma senza alcuna passione. Sapevo della vasta letteratura prodotta sul caso Moro, ma non avevo mai letto nulla, fino a quando, l’anno scorso, per caso, non lessi le lettere scritte durante la sua prigionia. Io sono uno psicologo e di conseguenza, leggendo, non prestai attenzione agli aspetti politici della questione, non m’interessavano; d’altra parte i “fatti” erano ormai lontani. Mi lasciai così coinvolgere soprattutto dalla vicenda umana di Moro: iniziai a valutare “quelle lettere”, da cui trasparivano intatti e vivi i sentimenti dell’uomo, unicamente con riferimento al prigioniero, ai suoi vissuti e alle ragioni invocate per la sua liberazione.
Il mio interesse per l’uomo Moro, tuttavia, non è terminato con la stesura del libro; al contrario, è iniziato con la sua pubblicazione. Io non sono in grado di comprendere quel che sta accadendo intorno al mio libro, ma trovo inquietanti i segnali che mi arrivano. Ho scritto molti libri, e non soltanto di psicologia, ma avverto che questa volta è diverso: qualcosa di Moro dà ancora tanto fastidio.
Il suo lavoro parte dal voler ribaltare l’atteggiamento comunemente attribuito a Moro, cioè “il non voler morire”, in un altro “il voler vivere”. Sembra una differenza sottile. A cosa porta, in termini di analisi, questo differente punto di partenza?
Sembra una differenza sottile, è vero, ma comporta un atteggiamento diametralmente opposto. È stato affermato che Moro non volesse morire, ed è stato di conseguenza dipinto un uomo in preda della propria paura, pronto a qualsiasi compromesso, anche a colludere con i brigatisti, pur di salvarsi. Chi non vuol morire è dominato dalla paura della morte, o almeno in questo modo noi lo immaginiamo. Ora, anche una lettura frettolosa e superficiale delle lettere sa offrire di Moro un’immagine totalmente estranea a quella che è stata ossessivamente illustrata. Io non ho trovato nessun elemento capace di rilevare in Moro la paura della morte. La morte stessa di Moro, in qualunque versione raccontata, è testimonianza di una grande padronanza emotiva e dell’accettazione di un destino, di cui egli resta Signore.
Dire che Moro desiderasse vivere comporta un diverso ritratto, quello di un uomo che non sente ancora di aver esaurito i motivi e i compiti per i quali diventa necessario esistere. Moro non era identificato alla propria maschera sociale, al personaggio noto agli ex amici; le dimensioni di Moro erano qualificate prioritariamente dai ruoli naturali, che la vita assegna, con riferimento a una famiglia. Moro non sentiva di avere motivi per morire, ma ne aveva molti per vivere. Chi pensa che Moro abbia scelto la famiglia e non lo Stato sbaglia. Moro non viveva per un’immagine, e non avvertì mai il bisogno di idolatrare la propria immagine politica; le sue ragioni erano guidate da un sentimento d’impegno nei confronti di coloro che gli erano stati affidati. La sua preoccupazione, che si estendeva a tutto ciò che rientrava nel concetto di famiglia, era vera. Moro era una persona sincera nei suoi affetti e nelle sue dichiarazioni; se noi non siamo in grado di credergli, o peggio, di non comprendere, il limite è tutto nostro.
La “Sindrome di Stoccolma” attribuita al prigioniero e con la quale si cercò di delegittimare l’autonomia di pensiero di Aldo Moro, è da lei letta “al contrario”. In pratica furono le BR a essere quasi “dipendenti” dalle volontà e, più generale, dalla personalità del loro prigioniero. Che cosa avrebbe potuto comportare un rovesciamento della “Sindrome di Stoccolma” al tempo del sequestro?
È ormai un dato acquisito che Moro non fu affetto da nessuna “sindrome di Stoccolma”; neppure si trova in lui un comportamento che possa essere letto come un tentativo d’ingraziarsi o di compiacere i suoi carcerieri. Se così non fosse stato, Moro non avrebbe potuto conservare attendibilità e rispetto presso chi lo torturava. Non chiese mai ai suoi sequestratori di liberarlo e così facendo, fornì prova di realismo e di coraggio, ossia di integre capacità cognitive di analisi e di valutazione della situazione. Chiese tuttavia ai suoi ex amici di risolvere un “problema”, che egli non viveva come suo soltanto, ma di tutti, opponendo a una ragione di Stato le ragioni di una Nazione. La storia diede ragione a Moro. Opporre forza è un modo illusorio di vincere le proprie paure, e le Brigate Rosse “hanno fatto” paura. Se soltanto si fosse desiderato comprendere quel che Moro cercava di suggerire, quando chiedeva fiducia in lui, ci si sarebbe reso conto che la sua liberazione sarebbe stata considerata come un atto di debolezza non dello Stato ma dei brigatisti. Il sequestro avrebbe perduto l’alone dell’ideologia e del gesto rivoluzionario, e sarebbe stato declassato a una mera azione di pusillanime “ricatto”. Dopo aver compiuto una strage, nulla poteva disorientare più di una liberazione; perché le Brigate Rosse fossero “credibili” nel loro delirio, non avrebbero mai dovuto aprire una trattativa con il Governo. Moro ebbe un grande ruolo in tutto questo. Il Governo ha reso forte l’immagine delle Brigate Rosse; Moro, da solo, le ha indebolite.
Nelle sue analisi, la speranza di Moro era di tornare ad essere chi era stato e quindi la disumanità della sua prigionia non disintegrò la sua identità. Lei ritiene, quindi, che se Moro fosse stato liberato sarebbe tornato pienamente cosciente del suo ruolo e recuperato appieno tutti i suoi poteri e identità politica?
È difficile rispondere a questa domanda. Intanto, Moro aveva in altre occasioni mostrato la volontà di ritirarsi dalla vita politica attiva. Accusa più volte, nelle sue lettere, Zaccagnini per averlo indotto ad accettare la carica di Presidente della Democrazia Cristiana. Sono tuttavia convinto che se ci fosse stata un’intesa con i “suoi” per la sua liberazione, egli avrebbe potuto continuare a esercitare la sua influenza. La sua intelligenza politica è fuori d’ogni dubbio. Moro aveva conservato, durante i giorni della sua prigionia, integra la sua dignità e autorevolezza, tanto da guadagnare il rispetto e la stima dei suoi carcerieri. Questi seppero riconoscere in Moro ciò che tutti gli altri non videro mai.
Moro era profondamente religioso e credeva nel valore dell’Uomo sopra ogni altra cosa. La pratica religiosa era una presenza costante nella sua vita, sin da giovane. La sua amicizia con Papa Montini era di lunga data e risaliva ai tempi dell’Università. Come ha preso, dal punto di vista religioso, Moro la lettera del Papa? Quel “il Papa ha fatto pochino. Forse ne avrà scrupolo” come può essere interpretato dal punto di vista di un uomo che quel “senza condizioni” ha contribuito a condannare a morte?
Moro ha lottato fino alla fine per evitare un lutto, non elaborabile, alla sua famiglia, e un danno irreparabile al Paese. Il Papa rappresentava l’ultimo tentativo. Penso che Moro abbia affrontato la morte nella pace, perché non aveva più nulla da rimproverarsi: ha fatto tutto quello che era in suo potere. Se desideriamo comprendere le parole di Moro, dobbiamo uscire dal nostro egocentrismo, e fare lo sforzo di valutare quelle parole il più obiettivamente possibile. «Il Papa ha fatto pochino», quel pochino va interpretato alla luce di quel che segue «Forse ne avrà scrupolo». Vi è qui una rima che improvvisamente si apre nella personalità di Moro e ci lascia intravedere una straordinaria sensibilità. Il Papa non ha fatto pochino per lui, ma innanzi tutto per se stesso; in altre parole, ha fatto pochino non con riferimento alle attese del carcerato ma rispetto a quello che, come Papa, avrebbe potuto fare, e per questo potrebbe avere degli scrupoli. Soltanto se cogliamo la preoccupazione di Moro per il Papa, possiamo comprendere quel “forse”. Molti invece hanno interpretato come se la frase dichiarasse: «Il Papa ha fatto pochino. Ne avrà scrupolo». Moro non augura alcuno scrupolo, ma si rammarica della possibilità di essere causa di un’amarezza per il Papa. Inoltre, implicitamente con quell’espressione Moro comunica la consapevolezza della propria morte. In questi dettagli si nasconde e si rivela la grandezza dell’uomo.
Nonostante l’omicidio di 5 uomini di scorta, i brigatisti sembrano cedere alla necessità di voler “adempiere alle ultime volontà” del Presidente. Lei definisce questo atteggiamento “un aspetto che ha la forma della pietà ma senza averne il potere. Infatti, non è pietà umana” e lo indica come il “lato oscuro delle Brigate Rosse”. Che cosa intende dire di preciso?
Dovremmo parlare della personalità dei brigatisti, e questo ci porterebbe lontano; inoltre preferisco ignorarli. Posso soltanto dire, parlando in generale dei terroristi di tutte le specie, che il loro movente primo è un misto di paura e di invidia. Per loro c’è un solo modo per vincere la paura e far cessare l’invidia, distruggere la fonte del potere che si teme e del bene che s’invidia: la fonte può essere identificata sia in una persona sia in un sistema. I terroristi sono affettivamente bambini, perciò manipolabili e pericolosi, per i loro processi cognitivi elementari e il loro fondamentale egocentrismo. Temerli è l’errore più grande, compiacerli la più grande colpa. Moro è il vero vincitore sui suoi carcerieri, li ha emotivamente disorientati e disarmati.
In molte lettere emergono i pensieri più intimi del prigioniero, i più sinceri. In breve, che dipinto è possibile ricavare dell’Uomo Aldo Moro analizzando i particolari più personali che emergono dalle sue lettere?
Il primo titolo del mio libro era: Aldo Moro, una personalità compiuta; poi è stato modificato con l’attuale titolo dall’editore. Se lo sviluppo psichico ha una meta, essa è sicuramente segnata dalla capacità dell’individuo di approdare affettivamente alla condizione di chi, esaurito il proprio credito dalla vita, ne diventa un debitore. Maturare in sé la gratitudine per la vita comporta la nascita del bisogno di sentirsi responsabili per gli altri in genere, per le nuove generazioni in particolare. Ho definito l’atteggiamento di Moro come ispirato dal sentimento di “responsabilità impegnata”, un sentimento proprio di una personalità genitoriale.
In molti passi dei suoi scritti emergono le premure che Moro aveva nei confronti dei suoi familiari. Parole che ci danno l’immagine di un uomo semplice, genuino. E’ comprensibile che all’epoca la cosiddetta “ragion di Stato” abbia impedito un riconoscimento pubblico della veridicità dei sentimenti umani che Moro provava e comunicava all’esterno. Ma questa è una tendenza che a distanza di oltre 30 anni non è mutata. Secondo lei perché?
Non fu “colpa” della ragione di Stato se Moro fu frainteso e rigettato; la ragione di Stato, semmai, fu il pretesto per evitare di comprendere Moro; e invocare ancora oggi, con testardaggine, una tale ragione ci fa capire quanto poco si è convinti. Che cosa dunque ostacolò e ancora impedisce di accogliere la verità dei sentimenti di Moro? Non è possibile! È un problema di livello evolutivo. Il brigatista magari sognava che il figlio abbandonato, una volta adulto, lo avrebbe idolatrato per aver “suo padre” scelto e preferito la lotta armata alla famiglia; una persona “adulta”, invece, non ha esitazione a frantumare l’idolo che lo abita, se il suo riconoscimento esige il sacrificio della propria famiglia. Il gesto eroico della personalità genitoriale sovente si consuma, per il filiale, in un’apparente viltà.
“Da parte mia non assolverò e non giustificherò nessuno” scrisse Moro in una famosa lettera al Segretario della DC Benigno Zaccagnini e rivolgendosi agli uomini del suo partito. Poi in uno scritto che non è possibile datare con certezza ma che tenderei ad escludere che possa essere considerato un brano del cosiddetto Memoriale, ringrazia i carcerieri dando “atto che alla generosità delle Brigate Rosse devo, per grazia, la salvezza della vita e la restituzione della libertà. Di ciò sono profondamente grato”. Probabilmente Moro pensò di aver avuto la meglio “umanamente” con i suoi carcerieri. Come reagì, psicologicamente, quando realizzò che sarebbe stato ucciso?
In quei cinquantacinque giorni di prigionia, Moro ricevette una terribile lezione di vita. Aveva pensato di avere degli amici e scopriva di non averne mai avuto. Di fronte alla morte, esperienza angosciante di per sé, e in una situazione drammatica, Moro conosce la solitudine e il tradimento da parte di chi aveva ricevuto tutta la sua amicizia. Non aveva capito nulla, anzi comprende ora quanto fosse stato ingenuo. Moro non può giustificare né assolvere nessuno, perché non riesce a perdonarsi di aver preferito il Partito, quel partito, alla Famiglia.
Penso che le parole di Moro, spese per i brigatisti, siano autentiche: sono le uniche parole con le quali manifestare i suoi sentimenti senza dover vergognarsi o pentirsi, poiché cristiano. Con il ringraziare i brigatisti, vale a dire coloro che gli hanno tolto tutto, cerca di comunicare qualcosa ai suoi ex amici, è una comunicazione rivolta direttamente al loro spirito. Non ci sono parole per dir loro nel modo più caritatevole possibile: voi siete i peggiori!
Per comprendere Moro, bisogna che passi questa generazione; per comprendere Moro c’è una condizione: conoscere se stessi. Abbiamo proiettato su Moro le nostre paure, i nostri pensieri, i nostri sentimenti; non è facile prendere coscienza che i nostri giudizi sono i nostri più sinceri giudici. Le tenebre non hanno conoscenza né consapevolezza dell’oscurità.
Un’ultima riflessione di carattere personale, stavolta. Che eredità ha lasciato Aldo Moro nella personalità del prof. Quaglia?
Moro ha affidato la sua verità ai pensieri trascritti durante la prigionia, il lettore che vuole in piccola parte avvicinarsi a questa verità è costretto a rivivere, se pure idealmente, la situazione in cui furono concepiti e affidati a fogli di carta. Chi riesce a fare uno sforzo e per alcuni attimi si lascia afferrare dall’angoscia che si addensava in quell’angusto vano, sicuramente non avverte più il desiderio di parlare di Moro, per rispetto, per pudore, per incapacità. Io mi sono, nella mia immaginazione, chiuso in quel bugigattolo per tutto il tempo che ho impiegato a scrivere questo libro; ho imparato osservando quest’uomo mentre cercava di prendersi cura della propria persona, mentre cercava di ascoltare quel che proveniva dall’esterno, mentre cercava di non disperare a ogni visita dei carcerieri, mentre pregava quando nessuno lo scrutava. Non avrei mai voluto scrivere questo libro.
|