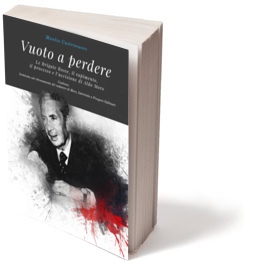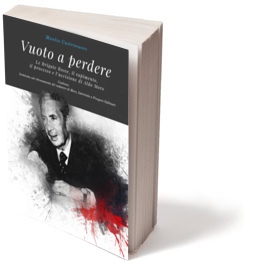|
Moro, trent'anni dopo.
Ma perché Cossiga non pubblica quel diario?
di Giuseppe Giacovazzo
Sopraffatto dagli incubi, Francesco Cossiga confessa: «Ho ucciso Aldo Moro a
cui debbo la mia immeritata vertiginosa carriera. Ma credo di espiare ricevendo
periodicamente dalla famiglia Moro l’epiteto di assassino». (La Stampa, 9 marzo
2008)
L’ultima volta gliel’ha detto, senza nominarlo, la vedova Eleonora Moro,
attraverso un colloquio con l’ex magistrato Ferdinando Imposimato, riportato nel
suo libro «Doveva morire». «Chi l’ha assassinato è vivo. E non penso ai
poveretti che l’hanno sparato. Prego Dio per lui affinché gli tenga la sua santa
mano sul capo. A quelli che l’hanno fatto uccidere non posso stringere la mano…
Quando li vedo, attraverso la strada e vado dall’altra parte».
La signora Moro ha varcato i 90 anni. Non abita più in via di Forte
Trionfale. L’ultima volta che andai a trovarla in quella casa tentai di
convincerla a raccontare quella parte della sua sofferta verità che ha taciuto
anche nei cinque processi. «No», mi disse con voce materna. E ancora no, con
quegli occhi azzurri che il tempo non ha appannato. «Mio caro, se parlo devo
dire la verità, e se dico la verità faccio del male non solo a me, che non me ne
importa niente, ma ai miei figli, ai nipoti… e anche a te che scrivi e sei
venuto qui a trovarmi». Poi mi accompagnò alla vetrata del balcone che dava
sulla strada dove avevo parcheggiato. «Ti ho visto mentre arrivavi, e subito
dopo s’è fermata dietro la tua auto una macchina nera… la conosco, la
conosciamo».
Non me la sentii di andare oltre.
Forse riaffiorava in lei l’ombra di quelle strane presenze non sempre
protettive, quei «servizi» che hanno avuto un oscuro inquietante ruolo nel
dramma della sua famiglia, manovrati da massime potenze. Donna Eleonora non ha
mai nascosto una sua convinzione: c’era la mano americana dietro il cosiddetto
partito della fermezza, che negò ogni seria trattativa per salvare Moro. E ora
ne abbiamo la conferma diretta.
Dopo trent’anni di silenzio si fa vivo quel signore americano scomparso, che
per conto della Casa Bianca sbarcò in Italia nel marzo del 1978 e tenne i fili
del sequestro Moro per i 55 giorni della prigionia. Molti si chiedevano che fine
avesse fatto Steve Pieczenick, fiduciario del presidente Carter, l’uomo che ebbe
carta bianca, fino a scavalcare, come fece, il fiacco ambasciatore Gardner.
L’inviato speciale americano prese in mano le redini dell’operazione appena si
rese conto che il governo Andreotti e il suo ministro dell’Interno Cossiga si
erano affidati a servizi segreti inefficienti e corrotti, infiltrati dalle
brigate rosse e in combutta con loro.
Ora finalmente l’americano racconta tutto per filo e per segno al giornalista
francese Emmanuel Amara in un libro senza equivoci, a partire dal titolo:
«Abbiamo ucciso Moro». Appena giunto a Roma, Steve capì subito che lo Stato
italiano era ridotto a un colabrodo. Ormai il governo aveva consegnato le chiavi
della sicurezza nazionale nelle mani della P2. A capo del Sismi e del Sisde
sedevano i generali Santovito e Grassini, iscritti insieme ad altri capi e
sottocapi alla loggia massonica di Licio Gelli che perseguiva un preciso
disegno: far fallire con ogni mezzo il dialogo avviato da Moro con Berlinguer
per la formazione di un governo di solidarietà nazionale. Ma dopo il sequestro i
vertici della Dc e lo stesso leader comunista dissero che trattare con le Br
significava infliggere un colpo mortale allo Stato. E si chiusero nella
fermezza.
In quella situazione caotica i brigatisti si muovevano liberamente per Roma
sotto il naso degli inquirenti ridicolizzati, e il governo impotente a guardare,
in mezzo a un intreccio di segreti inconfessati. Il fondatore delle Br, Curcio,
l’aveva detto in un processo: «Non possono parlare loro e non parleremo neppure
noi». Questo era il tacito patto con i servizi deviati, sottomessi alla P2.
Di qui la fallacia dei processi. E perché tutti gli assassini sono da tempo
in libertà. Ho visto e ascoltato di persona i brigatisti Moretti, Gallinari,
Peci, Savasta. Ho potuto a lungo parlare con Germano Maccari che dopo
l’uccisione nel garage di via Montalcini guidò la Renault rossa in via Caetani
col cadavere di Moro. Ho rifatto con lui, vent’anni dopo, quello stesso
tragitto. Neanche lui ci ha detto la verità, pur essendo già segnato dal male
che poco dopo l’avrebbe spento, ancor giovane. Non è chiara tuttora neppure la
dinamica dell’eccidio di via Fani, trent’anni dopo quel 16 marzo. E neppure il
numero dei brigatisti che spararono. Ci si chiede ancora come mai il covo di via
Montalcini fosse stato scoperto quattro anni più tardi. E la Braghetti vi
abitava ancora nel febbraio del 1980 quando assassinò all’Università di Roma il
professor Vittorio Bachelet.
Con questi misteri conviviamo dopo tre decenni. E il dolente Cossiga non sarà
facilmente affrancato dagli incubi che lo tormentano, fino a quando non si
deciderà a raccontare tutta la verità che conosce, finché non avrà spazzato via
la nebbia che copre ancora gli assassini di Moro e i loro complici più o meno
occulti. Ha detto di recente in una intervista che ha tenuto «un diario
giornaliero di quella vicenda e chissà che non lo pubblichi». Cosa aspetta?
Potrebbe aiutarlo a scongiurare quell’epiteto di assassino che periodicamente
gli cade addosso. Di chi ha paura?
Se davvero crede a un cammino d’espiazione, non è tacendo che si può espiare.
Così tutti continuiamo a espiare, consapevoli e non, un lutto italiano che non
riusciamo a cancellare, né dalla memoria né dalla storia. Così non si rende
giustizia a nessuno. Tanto meno a un martire che ancor giovane docente
universitario scriveva: «Forse il destino dell’uomo non è di realizzare
pienamente la giustizia, ma di avere della giustizia perennemente fame e sete.
Ma è sempre un gran destino».
di Giuseppe Giacovazzo ("La Gazzetta del Mezzogiorno" del 15/03/2008)
|